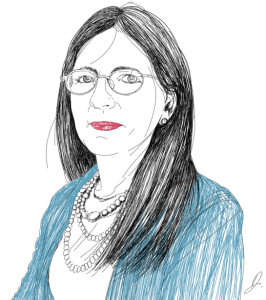È la vigilia di Natale, c’è la nebbia, è buio, fa freddo nel negozio, fa freddo nella strada ma il vero freddo è «il freddo che aveva dentro». «Gli gelava il viso, gli affilava il naso appuntito, gli raggrinziva le gote, ne induriva l’andatura, gli arrossava gli occhi, gli illividiva le labbra, si rivelava nella voce gracchiante. Una brina ghiacciata gli copriva il capo, sopracciglia e mento legnoso; ed egli portava sempre in giro con sé quella sua bassa temperatura, che gelava il suo ufficio anche nei giorni di canicola, e non saliva, sia pure di un grado, neanche al tempo di Natale».
Ebenezer Scrooge è il protagonista del Canto di Nataledi Charles Dickens1 e trascorre i giorni della sua vita scalpellato in un suo egoismo così compatto che il freddo dell’inverno nemmeno lo sente perché lo emana in proprio lungo tutto l’arco dei mesi e insieme ostinatamente s’impegna a credere che scelta non ci sia, a credere che la vita sia così, questo furioso difendere il proprio tangibile bene, fatto di cose che non si usano per risparmiarle a se stesse, di case che non si riscaldano per accumulare in banca titoli che non si godono perché hanno la missione di aumentare, sempre di più, sempre di più.
Difendere le cose e insieme difendersi dai sentimenti, sia mai che costino un regalo o anche solo una gratitudine, spiffero di vita che ci invade. Per cui l’affetto del nipote ostinatamente cordiale è solo molesto. Ma bisogna difendersi soprattutto dai sensi, «perché un nonnulla basta a turbarli. Un piccolo imbarazzo di stomaco può renderli ingannevoli». Benevolenza da buona digestione, sia mai che dopo ci si debba pentire. E in questo generale totale assoluto viaggiare solo e diffidente, la visita del socio Marley, peraltro del tutto defunto da sette anni, cade inizialmente sotto l’accetta del sospetto, come tutte le relazioni della sua vita circoscritta, serrata, inchiavistellata.
Triste lui, rattristati quelli che gli stanno intorno, come si fa a non vedere? Come facciamo tutti a non vedere la nostra infelicità?
Il socio Jacob Marley che arriva dall’oltretomba carico di una catena da lui stesso costruita in vita, fatta di «chiavi, lucchetti e libri mastri», spiega a Scrooge come a un bambino che non vuol capire. È la vita circoscritta la colpa e la condanna insieme, il non essersi mai allontanato dall’ufficio, mai «oltre gli stretti limiti del nostro minuscolo banco di cambio», gli occhi incollati a terra e ai beni e mai mai alla «stella benedetta che condusse i magi a una capanna».
Al di là del vortice di buoni sentimenti, di un mondo povero ma felice in cui Scrooge viene trasportato dallo spirito del Natale passato e dallo spirito del Natale presente, e anche al di là dell’orrore ormai scontato in cui lo precipita la visione del Natale futuro, che lo immerge nella realtà della sua morte e dello sciacallaggio da cui è circondata, il viaggio natalizio di Scrooge è sostanzialmente un vedere. «Vieni e vedi». Non sono le parole a trasformarlo ma il lineare vedere come ciò che si è scelto ha avuto conseguenze su di noi e sul mondo e come quel che faremo da ora in poi è ancora tutto nelle nostre mani, non è scritto.
Ciò che Scrooge impara è qualcosa che in fondo sappiamo ma dimentichiamo, e cioè che è la solitudine a disseccare la nostra umanità. Non è bene che l’uomo sia solo. Ed è la cecità lo strumento che ci permette di vivere così. Di non vivere così. Caino dov’è tuo fratello? Scrooge che esce dalla notte di Natale vivo dopo aver attraversato il suo funerale è un uomo che vede, improvvisamente vede: il tacchino da regalare, i gentiluomini che aveva cacciato senza fissarli negli occhi il giorno prima, e sente improvvisamente il freddo del negozio e la gioia della festa e la felicità di rendere felici, felice della felicità degli altri.
Chissà se il terribile peccato contro lo Spirito non è semplicemente questo negarsi alla vita, alla ricerca della propria piccola arruffata sgangherata felicità. Movimento rischioso, si può amare e perdere, partire e cadere. «Sono solo un mortale, potrei anche cadere», dice Scrooge al fantasma dei natali passati. La condizione di tutti è questo poter cadere ma permettere alla paura di inchiodarci a un destino che vogliamo credere scolpito è negarsi il bene che la vita disperde lungo gli anni che ci sono consegnati.
Questo movimento può sembrare forse sul principio e anche dopo, a tratti, più difficile e molesto del quieto restare al banco del cambio, che diventa poi faticoso difendere una posizione, arginare la forza del mondo di affetti e relazioni che naturalmente e senza pretese arriva, entra dalla porta nella forma del suono di mani che sbattono l’una contro l’altra per vincere il freddo, o piedi che scivolano sul ghiaccio mescolati alla voce di un bambino che canta canzoni di Natale.
Aprire gli occhi alla vita è realtà prima che metafora e se non cambierà il mondo intero cambierà il nostro mondo e quello di un bel po’ di persone che ci stanno intorno. Non è poco, proprio no.
1 Charles Dickens, A Christmas Carol, Londra 1843; la versione qui citata è tratta da Il canto di Natale, Rizzoli, Milano 2015.